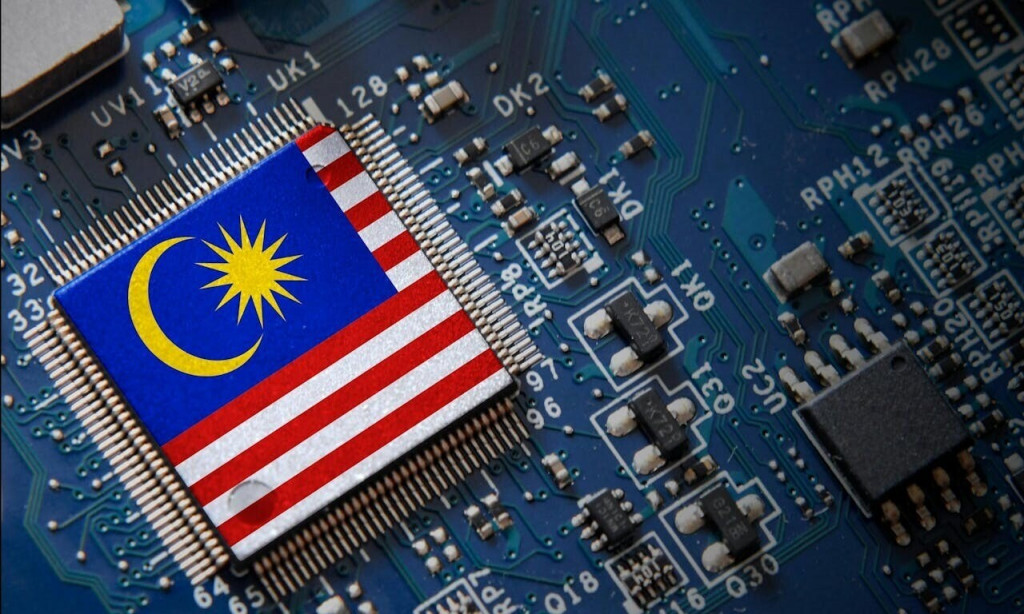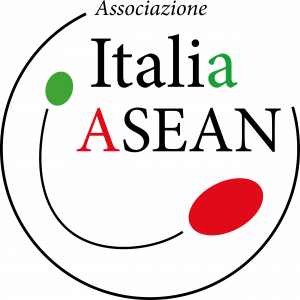I Paesi ASEAN sono stati colpiti duramente dai dazi americani. La politica commerciale non convenzionale di Donald Trump impone risposte, a loro volta, inedite. Per ora prevalgono cautela e volontà di trattare, ma il ruolo di Washington (e di Pechino) nella regione è destinato a cambiare.
Articolo di Pierfrancesco Mattiolo
Alla fine, i dazi promessi da Donald Trump sono entrati in vigore. Non quelli annunciati durante il famigerato Liberation Day dello scorso 2 aprile, sospesi alcuni giorni dopo per una durata di tre mesi, probabilmente in reazione al crollo di Wall Street. Per il momento, si applicherà solo un dazio generale del 10%, con alcune eccezioni: i dazi sopra il 100% contro la Cina; acciaio e alluminio con tariffe al 25%; l’esclusione per alcuni prodotti, tra cui i semiconduttori. Durante la campagna elettorale, Trump aveva agitato l’idea di un aumento delle tariffe tra il 10% e il 20%, quindi l’attuale assetto si può considerare una promessa mantenuta, anche se la natura imprevedibile dell’attuale esecutivo USA rende difficile prevedere quali saranno i dazi tra un anno, un mese o una settimana. I dazi al 10% rimangono comunque alti e segnano forse l’inizio di una fase di profonda incertezza per l’economia globale.
Se la tabella mostrata da Trump durante il Liberation Day fosse effettivamente applicata in futuro, i dazi per quasi tutti i Paesi ASEAN si alzerebbero rispetto alla soglia di partenza del 10%. In ordine decrescente, la Cambogia sarebbe colpita da un dazio del 49%; Laos, 47%; Vietnam, 46%; Tailandia, 36%; Indonesia, 32%; Malesia e Brunei, 24%; Filippine, 17%. Solo Singapore rimarrebbe al 10%, dato che è l’unico Paese a importare dagli USA più di quanto esporta. Come ampiamente osservato da analisti e stampa internazionale, queste “tariffe reciproche” non sono basate sui dazi imposti dai partner commerciali sulle merci americane, come affermato dalla Casa Bianca, bensì sul disavanzo commerciale tra ciascun Paese e gli Stati Uniti. Una scelta criticata, che mette in difficoltà questi Paesi: anche riducendo i propri dazi sui prodotti statunitensi, il disavanzo commerciale si potrebbe forse ridurre, ma comunque non invertire del tutto, e non certo per sola iniziativa governativa. La visione mercantilista dell’attuale Amministrazione, inoltre, esclude dalle proprie considerazioni che le sue aziende importano sì molti beni a basso costo dall’estero, ma godono poi di alti margini quando vendono il prodotto finale al consumatore statunitense o di un altro Paese. Inoltre, l’economia USA, la più avanzata al mondo, può concentrarsi sull’esportare servizi e sull’attrarre investimenti e risparmi, in nome del principio di specializzazione. Trump rompe con la visione del commercio internazionale che ha dominato per decenni l’agenda dei governi di quasi tutto il mondo.
Un altro elemento “poco ortodosso” della politica commerciale di Trump è imporre un dazio generale su tutti i prodotti, da tutti i Paesi. Di solito, i governi non usano misure “one-size-fits-all” in politica commerciale. I beni che non produci avranno un dazio basso; quelli che vuoi continuare a produrre sul tuo suolo, magari per motivi politici o strategici, ne avranno uno alto. Se vuoi ottenere maggiore accesso al mercato di un altro Paese (ossia una riduzione delle tariffe sulle tue merci), solitamente dovrai offrire maggiore accesso al tuo, scegliendo su quali merci ha più senso ridurre bilateralmente i dazi. La politica commerciale UE nella regione, come dimostrato dagli accordi di libero scambio con Vietnam e Singapore, segue questo approccio. Trump si muove in tutt’altra direzione o, meglio, sembra considerare questi aspetti solo in un secondo momento, ad esempio esonerando dai dazi prodotti essenziali e prodotti all’estero, come i semiconduttori.
Infine, l’ultimo elemento di rottura tra la politica commerciale di Trump e quella “convenzionale” riguarda il suo obiettivo dichiarato. O meglio, il fatto che Trump non ne abbia (solo) uno, definito chiaramente. Ad ascoltare il Presidente e i suoi collaboratori, l’Amministrazione sembra inseguire molteplici scopi, anche in parziale contrasto tra loro. Aumentare le entrate del governo federale per ridurre altre tasse? Riportare certe industrie negli Stati Uniti? Ridurre o eliminare i disavanzi commerciali? Ottenere concessioni su altri dossier politici o economici? Imporre ai Paesi terzi di non cooperare con i rivali geopolitici degli USA, Cina in testa? Come osservato dalla rivista The Diplomat, tale ambiguità rende difficile per i Paesi ASEAN (e non solo) capire cosa vuole Trump e come accontentarlo, spingendoli alla conclusione che, forse, Washington non voglia togliere le tariffe del tutto. Tale worst-case scenario sembra confermato dal commento di Peter Navarro, il consigliere commerciale di Trump, in risposta alle prime offerte concilianti del Vietnam: “non significano nulla per noi”, il Vietnam è un punto di “trasbordo” dei prodotti cinesi ed è “essenzialmente una colonia della Cina comunista”.
Come possono reagire le cancellerie della regione, dunque? Per il momento, prevale la cautela e la ricerca di un accordo con Trump. Come dimostrato dal Messico, questo approccio sembra il più indicato per rimandare l’entrata in vigore dei dazi. Nessun Paese ASEAN ha imposto dazi di rappresaglia: se la politica commerciale di Trump rompe con i precedenti consolidati, anche la risposta degli altri Paesi lo fa. Se continueranno così, i governi ASEAN daranno in parte ragione a Trump, che aveva promesso alle aziende americane che non avrebbero subito rappresaglie, dato che i partner si sarebbero affrettati a fargli concessioni – o, per usare un’espressione di Trump, “baciargli il c…”. Molti Paesi ASEAN hanno offerto la riduzione dei loro dazi e del disavanzo commerciale, comprando più prodotti USA e diversificando le destinazioni del loro export. Tornando al caso del Vietnam, se le parole di Navarro non sono incoraggianti, quelle di Trump in persona lo sembrano – il Presidente ha definito una chiamata tra lui e il Segretario Generale To Lam “molto produttiva”. Hanoi ha anche stretto accordi con Starlink, l’azienda spaziale di Elon Musk, probabilmente per ottenere un alleato nell’entourage di Trump. Dato che la posizione dell’Amministrazione Trump è solo quella del Presidente Trump, più che quella dei suoi collaboratori, avere Navarro contro e Musk a favore fa poca differenza, specie con Musk sempre meno coinvolto nelle scelte dello Studio Ovale.
Più difficile sarà invece per Trump imporre una rottura, commerciale e politica, con la Cina. Ad esempio, il giornalista David Hutt, esperto di Cambogia, ha osservato che gli Stati Uniti potrebbero chiedere a Phnom Penh di rivedere la cooperazione con i cinesi sulla base navale di Ream in cambio di una riduzione dei dazi. I Paesi ASEAN, però, potrebbero voler fare l’esatto contrario: se non si può esportare verso gli USA, si può pur sempre commerciare tra Paesi colpiti dalle tariffe, Cina inclusa. Pechino ha colto l’opportunità e si presenta oggi come affidabile paladina del libero commercio, alternativa all’imprevedibile Washington. L’attenzione critica degli analisti e dei governi si è in parte spostata dalle pratiche commerciali aggressive cinesi ai dazi americani. Il leader cinese Xi Jinping ha già iniziato una serie di visite ufficiali e ha incassato un successo simbolico con il riavvio della cooperazione commerciale con Giappone e Corea del Sud – durante gli anni dell’Amministrazione Biden, i tre Paesi non avevano mai dialogato in materia, anzi, si erano allontanati. I governi ASEAN, abituati a destreggiarsi tra le due potenze del Pacifico, continueranno a farlo, con l’unica differenza che ora gli Stati Uniti sono percepiti come meno affidabili e prevedibili. La “ritirata strategica” USA dalla regione, però, non lascia spazio solo alla Cina: l’Unione Europea diventa un potenziale partner commerciale e strategico più importante.Per il Sud-Est asiatico, cooperare a livello ASEAN può fornire un mezzo per resistere all’approccio divide et impera di Trump. L’attuale presidente dell’Associazione, la Malesia, si è impegnata a trovare una risposta coordinata a questa sfida al modello economico della regione, basato sull’export. Anche se i Paesi membri sono stati colpiti in misura differente, rispetto ai dazi della prima Amministrazione Trump, le opportunità sembrano molto inferiori rispetto ai rischi. Negli ultimi anni, alcune economie, come quella vietnamita, avevano tratto vantaggio dal decoupling tra USA e Cina, attirando buona parte della produzione delle merci da esportare in America. Proprio questo ha fatto crescere il disavanzo commerciale, portando ai dazi più alti imposti da Trump. Il messaggio del Liberation Day è che conquistare maggiori quote di mercato statunitense, e fare più affidamento su quell’export per il proprio sviluppo, rischia di penalizzare un Paese in futuro. Se le tensioni commerciali del primo mandato sembravano un gioco a somma zero con vincitori e vinti – in linea con quella che sembra la visione del mondo di Trump –, questa volta tutti sembrano destinati a perderci. L’incertezza causata dalle scelte poco prevedibili e mutevoli di Trump, in rottura con il pensiero economico dominante, rischia di avere effetti negativi sugli investimenti e sull’economia in tutto il mondo.