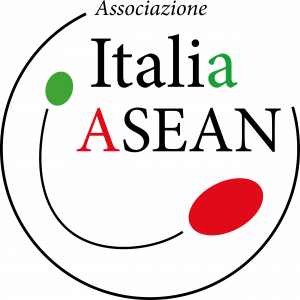La presidenza dell’ASEAN di Vientiane ha fatto segnare progressi rilevanti sul dossier Myanmar. Il linguaggio più morbido è probabilmente volto a “corteggiare” la giunta, allo scopo di non allontanarla dai forum di dialogo, ma anche a responsabilizzare i ribelli
Di Francesco Mattogno
Da qualche anno a questa parte l’ASEAN, nata per favorire l’integrazione economica tra gli stati regionali, è costretta a non occuparsi più solo di economia, investimenti e commercio. Alle decennali tensioni sul mar Cinese meridionale tra la Cina e vari Paesi membri (Filippine, Vietnam, Malesia, Brunei, Indonesia) si è aggiunta la guerra civile in Myanmar, che dal 2021 è il vero dossier caldo di ogni ministeriale e summit dell’associazione. È stato così anche a Vientiane.
Nonostante diversi osservatori e analisti temessero che il ridotto peso diplomatico del Laos potesse minare gli sforzi del gruppo per trovare una soluzione alla crisi birmana, la presidenza laotiana è stata invece la più significativa in tal senso, anche se non solo per meriti di Vientiane. Per la prima volta in oltre tre anni un rappresentante non politico della giunta militare birmana (ovvero il segretario permanente del ministero degli Esteri, Aung Kyaw Moe) ha partecipato a un vertice ASEAN, aprendo almeno idealmente alla prospettiva di un dialogo regionale volto a favorire il ritorno della pace in Myanmar.
La presenza di Aung Kyaw Moe a Vientiane va registrata all’interno di un processo in corso già da diversi mesi. A seguito delle enormi perdite territoriali dell’ultimo anno, la giunta birmana, alla ricerca di legittimità internazionale, ha assunto un atteggiamento più aperto e dialogante nei confronti dell’associazione. Nell’aprile del 2021, due mesi dopo il golpe, l’esercito aveva firmato con l’ASEAN un documento (il “Consenso in 5 punti”) nel quale si impegnava a interrompere le violenze e ad avviare un dialogo con tutte le forze di opposizione al regime, salvo poi violare ogni termine dell’accordo. Da tre anni la giunta bombarda regolarmente i civili e si riferisce alle forze di resistenza come “terroristi”: non proprio un segnale di grande propensione a delle trattative di pace.
Come conseguenza del mancato rispetto del Consenso in 5 punti, l’ASEAN ha vietato all’esercito birmano di presenziare a ogni incontro dell’associazione, permettendo al regime di inviare solamente dei “rappresentanti non politici”, cioè segretari e membri dell’amministrazione. Per quasi tre anni Naypyidaw si è rifiutata di farlo, ritenendolo un affronto, prima di cambiare idea lo scorso gennaio alla luce dell’avanzata dei ribelli in gran parte delle periferie del paese. Con la presidenza del Laos – la cui leadership mantiene rapporti ambigui con il regime birmano – è cominciato dunque un graduale reinserimento del Myanmar all’interno dei meccanismi del blocco, e sono arrivati anche i primi (piccoli) risultati diplomatici.
Si è iniziato a muovere qualcosa già alla vigilia degli incontri di Vientiane (6-11 ottobre). La settimana precedente al summit l’Indonesia ha ospitato i rappresentanti dei paesi ASEAN, insieme a quelli di Unione Europea, Stati Uniti, Nazioni Unite, India, Giappone e ai rappresentanti dei gruppi di resistenza in Myanmar per parlare della crisi birmana (non erano presenti né la giunta, che avrebbe rifiutato l’invito, né la Cina). I dettagli dell’incontro non sono stati divulgati, ma pochi giorni dopo la prima ministra thailandese, Paetongtarn Shinawatra, si è detta disponibile a ospitare a Bangkok i rappresentanti dei paesi ASEAN allo scopo di presentare nuove proposte di pace per il Myanmar. L’associazione ha accettato, e i colloqui si terranno a dicembre.
Come ha scritto Sebastian Strangio sul Diplomat, l’ASEAN sembra essersi resa conto di dover adottare un approccio più creativo e flessibile alla crisi birmana. Lo ha ammesso anche il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr, che ha parlato della necessità di trovare «nuove strategie». L’evolversi della situazione sul campo, con l’avanzata dei ribelli, ha reso obsoleto il Consenso in 5 punti fondato sulla centralità del ruolo dell’esercito, che ormai non controlla più de facto vaste porzioni del territorio birmano. Il rischio quindi è che i vicini del Myanmar esterni all’associazione (Cina, India, Bangladesh) diventino più influenti ed efficaci dell’ASEAN nel trovare una soluzione al conflitto. L’India, ad esempio, ha invitato vari gruppi ribelli a partecipare a una conferenza sul federalismo che si terrà a novembre a Nuova Delhi.
L’ASEAN starebbe quindi iniziando ad accettare la legittimità delle forze di resistenza birmane, dalle milizie etniche armate (EAO) alle People’s Defence Forces (PDF) che fanno riferimento al governo democratico in esilio. Lo si noterebbe anche dal comunicato congiunto sul Myanmar pubblicato in settimana. Il documento è meno duro rispetto a quello del 2023, nel quale i paesi membri dichiaravano esplicitamente che l’esercito birmano fosse il principale attore responsabile degli attacchi ai civili, ed esorta «tutte le forze armate» a ridurre il livello delle violenze.
Se da un lato il linguaggio più morbido è probabilmente volto a “corteggiare” la giunta, allo scopo di non allontanarla dai forum di dialogo, dall’altro potrebbe anche essere finalizzato a responsabilizzare i ribelli, riconoscendogli un ruolo importante nelle logiche del processo di pace. Eventualità che l’approccio stato-centrico del Consenso in 5 punti non teneva in considerazione. È vero anche che molti gruppi della resistenza sembrano ormai restii al dialogo. Forti delle numerose vittorie sul campo, sempre più EAO ambiscono alla rivoluzione e non vogliono sentir parlare di trattative di pace. O in alternativa chiedono come condizione di partenza la totale resa della giunta, con annessi processi per crimini di guerra e contro l’umanità a carico dei vertici e dei soldati dell’esercito regolare. Una prospettiva che i militari non sono disposti ad accettare.